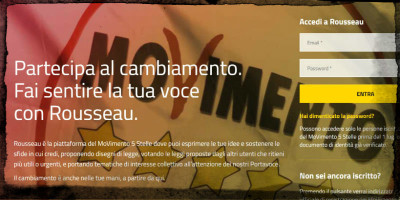Un giorno o l’altro, non necessariamente un Giorno del Ricordo, dovrei mettere per iscritto la mia annosa diffidenza nei confronti di La vita è bella. Ha a che vedere col concetto di Shoahsploitation, parola che mi sono inventato e non ne vado fiero, anche perché alla fine è inutile prendersela: se imponi un momento di approfondimento tutti gli anni in tutte le scuole è inevitabile che nascano prodotti che servono esattamente a questo, magari si può rimarcare che Benigni/Cerami sono stai tra i primi a capire che razza di mercato si stava aprendo. Cruciale fu l’incontro con Mihăileanu, che aveva già in mente il concept di Train de vie e pensava a Benigni un protagonista: forse non capiva di avere davanti anche un uomo produttore abbastanza scafato che poteva copiargli l’idea.
La mia diffidenza ha a che vedere con l’equivoco per cui quello che chiediamo a questi prodotti ‘leggeri’ a tema Shoah è un motivo per parlare di Shoah a un’età in cui rischiamo di scioccare i bambini. Servono a questo. Il problema è che forse li scambiamo per punti d’accesso all’argomento, laddove manco ci provano: La vita è bella non “spiega” la Shoah, non introduce alla Shoah (neanche Train de vie, neanche Jojo Rabbit). Sono film che rimangono nei dintorni, raccontano episodi veri o inventati intorno all’argomento, cercano di non risultare troppo depressivi o disturbanti e ti danno la sensazione che hai passato un paio d’ore a ricordare la Shoah. Nel frattempo i ragazzi crescono, un 27 gennaio dopo l’altro hanno effettivamente il tempo per imparare qualcosa, per cui alla fine qualcosa passa: è più liturgia che didattica, comunque.
Di tutti questi film La vita è bella è il più pervasivo, al punto che alla fine della scuola dell’obbligo i ragazzi rischiano di averlo già visto due o tre volte, di associare per sempre la faccia grulla di Benigni all’ebraismo, che già tante offese ha patito e sopravvivrà indubbiamente anche a questa, però forse il mio fastidio parte proprio da Benigni, e dal concetto del film, che non riesco ad accettare (non da un punto di vista morale, è proprio la sospensione dell’incredulità che non mi scatta): un padre che convince un bambino che Auschwitz è un gioco a premi. Questo pone tutta una serie di problemi.
a) Non si ingannano i bambini – cioè, succede spesso, ma costruirci sopra un film è discutibile. Proporre questo film ai bambini è proprio un corto circuito che m’infastidisce.
b) I bambini non sono mica deficienti, cioè come fai a credere che Auschwitz sia Takeshi’s Castle (se tra l’altro non hai mai visto Takeshi’s Castle), davvero quel bambino non può crederci davvero, l’unica strategia che trovo per reggere la visione è immaginare che sia lui che sta prendendo suo padre per scemo, gli regga la candela perché altrimenti suo padre non potrebbe fare più il pagliaccio, e a quel punto gli prenderebbe la depressione.
c) Questa finzione dipende tutta appunto dalla capacità di Benigni di fare il pagliaccio. Tutto il film posa sulle spalle di questo tizio che manco fosse Charlie Chaplin, cioè se chiedevano a Charlie Chaplin lui probabilmente gli avrebbe detto no, guardate, neanche io riuscirei a rendere credibile una situazione del genere, e sono il più grande pagliaccio del mondo, ma se potessi fare un film del genere l’avrei fatto, e se non l’ho fatto c’è un motivo (anche Jerry Lewis all’ultimo momento ha bloccato tutto, vi ricordo). Benigni osa dove non ha osato Jerry Lewis, e il problema è che non è nemmeno il Benigni al top della forma, cioè per gran parte del film è il Benigni al minimo sindacale che ti ride in faccia e si aspetta che ridi anche tu per simpatia.
d) L’idea del campo come concorso a premi mi sembra anacronistica, anche se capisco che in epoca di Squid Game possa ritornare interessante (e qui potremmo aprire una digressione su quanto sia disumano il concetto di concorso a premi, e in generale la gamification della realtà che proprio nei Paesi dove è più avanzata ha prodotto fiction come Battle Royale o Squid Game).
Beh alla fine forse ce l’ho fatta, ho messo per iscritto quasi tutti i problemi che ho con la Vita è bella, senza nemmeno toccare l’annoso problema dei carri armati, che quando finalmente arrivano, sono quelli americani. Ma davvero mi sembra l’ultimo dei problemi, anche gli americani qualche campo l’hanno liberato. Ne approfitto per dire che per quanto m’infastidisca La vita è bella, forse funziona meglio di altri prodotti pensati per la scuola e più nobili, come La tregua di Rosi che in teoria non ha niente che non va e in pratica non gira, non saprei dire il perché, io alla fine quando vedo che un film non gira non lo guardo più e dopo un po’ mi dimentico il perché.
via Blogger https://ift.tt/SACRlBK